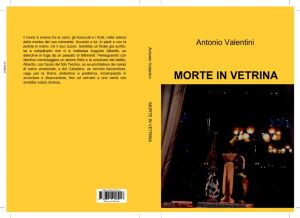Monica
Fui nel punto in cui i personaggi della mia storia avrebbero dovuto lasciarsi che alzai gli occhi oltre la vetrata, ai fregi delicati dei palazzi, ai tenui colori delle facciate, in quella moderazione cromatica che rendeva tutto indeciso, eppure indelebile ed elegante, come una bella calligrafia. Mi accorsi così che quella vaghezza mi era familiare, come se il mio quartiere e la mia persona se la imprimessero a vicenda, per osmosi, e capii che anche la storia che stavo scrivendo non poteva avere un esito conclamato. La lei e il lui che tratteggiavo, più che dividersi per sempre, si sarebbero sottratti l’uno all’altra, ma anche a se stessi e allo scenario, fino a divenire trasparenti, sfumando nel nulla, a lasciare pagine vuote, come i colori sepolti da secoli si sfarinano alla luce improvvisa del presente. Prima che il senso di nientificazione facesse sparire quello scorcio urbano davanti ai miei occhi, trascinandomi con sé, cercai con lo sguardo qualunque cosa che avesse un colore carico, una pregnanza anche volgare, lucida e immutabile come un’invadenza, e per fortuna la trovai. Passava nel marciapiede opposto, pencolando come un trampoliere sui suoi tacchi alti, lustra di gel nei capelli neri, la maschera facciale occhiuta di fard e di rossetto sanguinario, il giacchino di pelle aperto come un portale, a favorire le sporgenze dei seni, le gambe diritte e implacabili. Ebbi una sete improvvisa del suo profumo, che per quanto intuissi eccessivo non potevo certo annusare dall’alto. Per questo mi precipitai verso la porta di casa, scendendo in fretta le scale e schivando nell’androne la sagoma stanziale del portiere. Svoltai l’angolo e la vidi cinquanta metri più avanti, nel suo passo oscillante e indifeso, da equilibrista. Raggiungerla significò entrare nella sua storia, nello stesso momento in cui ne ideavo quei pochi particolari che sfuggivano a un’esatta identificazione. Una così non poteva che chiamarsi Jessica o Pamela o Vanessa e venire lì in centro con la metro dalla Subaugusta, per fare la commessa in un negozio di abiti femminili. Cercai un modo per abbordarla, anche se nel mio bagaglio tecnico non ce n’era nessuno. Avevo altre maniere per rapportarmi a una donna che mi intrigava eppure, nell’affiancarla, prima che i suoi occhi che già mi squadravano diventassero sospettosi, trovai una domanda spiritosa, squallida ed efficace.
“Scusami. Vado bene per dove mi pare?”
La sconsiderata sorrise e subito se ne pentì, volgendo gli occhi sul suo percorso e aspettando che dicessi qualcosa di più convincente.
“Sai una cosa? Prima che ti vedessi, dalla mia finestra, così viva e colorata, questo quartiere mi stava morendo sotto gli occhi.” dissi.
Lei allora mi guardò più a lungo, come se questo le consentisse di leggermi dentro e di prendermi le misure. Quando capì che non poteva farcela, almeno per il momento, distolse gli occhi e disse:
“Mi piace l’idea.”
“Lascia che te la spieghi, prima di apprezzarla.”
Lei chiuse gli occhi sorridendo, del tutto convinta o del tutto avvinta al gioco, che magari poteva distrarla per un poco dalla sua routine.
“Devi sapere che io scrivo storie per il cinema, partendo spesso da un particolare che ad altri potrebbe sembrare insignificante. – aggiunsi, prendendomi una pausa, ma solo per toccarle delicatamente una spalla – Insomma ti ho visto dalla finestra, rapito dalla pregnanza dei tuoi colori e mi sono detto che una ragazza così viva non poteva abitare in un quartiere così morto. Sono certo che vieni qui per lavoro, prendendo la metro A, forse da Cinecittà; che ti chiami Pamela o Jessica e che fai la commessa.”
La sua risata piena sembrò portarmi la zaffata decisiva del suo profumo fruttato, denso e sgargiante, come un sentore tropicale.
“Oppure ti chiami Marika e fai la cassiera in un market.” dissi.
Lei, che si era accesa una sigaretta, fece una faccia furba da clown bianco, sbuffando il fumo, con la corta consapevolezza della sua storia.
“Sbagliato.” disse.
“Certo può essere che abiti a Pantano, sulla Casilina, e che vieni in centro con la ferrovia urbana.”
“Tutto può essere. L’unica certezza è che la tua fantasia fa cilecca.”
“Io però la lascio correre. Tanto è un cavallo che torna.” dissi.
Camminavamo lentamente, con passi dipendenti dal dialogo, che si teneva al di qua di un’ironica diffidenza.
“Dunque non fai la commessa e non prendi la metro. Però è nel bar grande, qui in piazza, che fai il tuo snack, all’una, ed è lì e a quell’ora che ti aspetterò.” dissi.
La mia proposta le assottigliò un sorriso muto, concentrato su un’idea imprecisa e che pure sembrava scorrere davanti al suo passo.
“Mi chiamo Monica e abito a Ponte Marconi, lavoro nello studio di un commercialista e non faccio lo snack nel bar in piazza, davanti al quale non ti incontrerò, all’una.” disse.
“D’accordo, facciamo all’una e un quarto.” dissi io.
Lei scosse il capo, ancora divertita, poi scappò verso il commercialista che mi figurai ancora giovane e calvo, pallido e bisognoso del trucco carico e deferente di lei. Io invece tornai in fretta verso casa, cominciando a scrivere su un foglio gli sviluppi ipotetici della sua storia. Guardando i rari mobili antichi del mio studio, decisi che Monica abitasse in una casa piena di mensole e di ninnoli di peluche, con copie banali di panorami azzurri e di gialli tramonti alle pareti, a parte la foto incorniciata con il suo lui, forse un Fabio carrozziere, le mani più vecchie della giovane faccia, l’occhio nervoso e lo stomaco già enfiato dai troppi carboidrati. Fabio che regala l’uovo con la pantera rosa a pasqua, fedine d’oro già scambiate, l’amore del sabato sera in macchina, anche se Monica e lui si vogliono solo una parte di bene, perché il resto è sperduto nella tentazione del gioco, o nel gioco della tentazione. Fabio non dice a Monica di quando sale nella mansarda di Tina, la divorziata a cui ha rifatto così bene lo sportello della Ka. Monica non gli racconta che succede quando lei e il suo principale chiudono la porta e abbassano le tapparelle, per consumare respiri stropicciati, sul divano dell’ufficio. Storie parallele e senza attrito, che non rendono opachi i monili che si regalano ai compleanni.
Scrivevo con certezza brutale, certo della storia e della possibilità di entrarci quando volevo, creando l’imprevisto. Uscii di casa all’una, giungendo in fretta davanti allo snack bar, già pieno di impiegati in pausa pranzo. Cercai fra i tavoli esterni la figura di Monica e mentre mi apprestavo a sbirciare nell’interno sentii un pizzico sul dorso della mano e mi voltai, trovandomela davanti.
“Ho voluto che ne azzeccassi almeno una.” lei disse, ridendo.
“Mettiamola così. Ti offro un caffè?”
“Già preso. Dinne un’altra.”
“Un amaro.”
“Non bevo alcoolici.”
“E fai bene. Quelli in commercio sono nocivi. A casa però ho un liquore alle rose, fatto da mia zia. Vieni a berne un goccio, ora?”
“E andiamo. – lei disse – Voglio vedere che altro inventerai.”
Nell’androne il vecchio portiere la guardò a lungo e in ascensore lei scaricò l’ansia canticchiando fra sé un motivetto in voga. In casa, a metà corridoio, lei che camminava davanti si voltò, io le toccai una mano per saggiare il momento e lei mi appoggiò l’altra sul petto, troppo debolmente per volermi davvero respingere. Così l’abbracciai, appoggiandola al muro e assaporando la sua saliva, che presto prese il gusto del suo rossetto alla vaniglia. Cominciammo ad accarezzarci e all’improvviso lei mi respinse, guardando l’orologio che aveva al polso.
“Devo tornare al lavoro.” disse.
“Peccato. L’argomento si faceva interessante.”
“Se hai pazienza fino a stasera…”
“Passo a prenderti dove?” chiesi.
Invece di rispondermi frugò nella borsetta, traendone un biglietto da visita che mi porse.
“Ti aspetto alle nove. Per l’intanto scrivi il seguito della storia che hai immaginato su di me.” disse, già sulla porta di casa.
Scrissi davvero lo sviluppo degli eventi, fitto come i palazzoni squallidi di viale Marconi e immaginai il suo mini appartamento fra altri cubicoli rumorosi, con la puzza di soffritto nelle scale, le urla storpiate delle massaie sui grugniti dei mariti, l’abbaiare schizzato dei cani da salotto sull’andamento delle esistenze, fallito e incastonato nel cemento.
Verso sera indossai un paio di jeans e una camicia pulita, presi la macchina e mi avviai, passando senza accorgermene da una guida tranquilla a un procedere frenetico, man mano che le strade periferiche si riempivano di macchine e i quartieri si rabbuiavano nella densità edilizia e nell’assetto sommario delle vetrine dei negozi. Trovai il portone di Monica e suonai al citofono e quando lei rispose dissi il mio nome.
“Lamberto chi?” lei disse, per provocarmi.
“A Lamberto verrà aperto.” io dissi, accettando lo stupidario di quei preliminari.
La trovai vestita a truccata di tutto punto, quasi volesse propormi una cena fuori, tanto per tergiversare, invece mi condusse in un tinello arredato con mobili laccati di rosso, come una casa di Barbie. Su un tavolo da Chinatown, coperto da una tovaglia viola, quasi fossimo in quaresima, Monica aveva approntato una cena presa dal rosticciere e io capii di essere arrivato alla sorgente della scia di frittura che permeava il condominio. Eppure quel contesto pacchiano sembrava acuire la mia eccitazione, tanto che le cinsi la vita, cercando di rovesciarla su un divano. Lei si lasciò baciare, ma pian piano fece resistenza, spingendomi con delicata fermezza un ginocchio sui genitali.
“Ma dai, sta un po’ buono, guarda che cenetta ti ho preparato. Ma forse tu hai un altro tipo di digiuno.” disse.
“Se anche fosse, tornerebbe a tuo vantaggio.” risposi, sedendomi davanti a un piatto di cannelloni che non avrei mangiato nemmeno sotto tortura. Per farmi coraggio bevvi un sorso di lambrusco, sulla scia del quale quella mistura di carne dai dubbi natali, affogata nel sugo oleoso, si fece strada in qualche modo. Guardavo lei che mantecava i suoi bocconi col rossetto recuperato a strascico, con rapidi colpi di lingua, e pensai a un film di Tarantino, con l’irruzione improvvisa del suo ragazzo, di certo Fabio e indubitabilmente carrozziere, che sparava per gelosia a tutti e due, provocando un’indecifrabile poltiglia di sangue, olio, pomodoro, rossetto cipriato e schegge di plastica laccata di rosso. Eppure quella terribile situazione di disgusto non mi smontò, anche quando Monica, spinta da un impulso affettuoso, tranciò un pezzo di cannellone dal suo piatto e mi imboccò con la sua forchetta. Ci bevvi sopra dell’altro Lambrusco e ruppi gli indugi, abbracciandola e attirandola verso il divano, mentre le sue ritrosie si spegnevano. Le avevo già sfilato la camicetta quando il telefono squillò, confuso fra i dialoghi reali e televisivi che ci circondavano, non trattenuti dalle membrane spacciate per tramezzi. Benché io la invitassi a desistere, lei andò a rispondere, guardandomi mentre ascoltava, come se io fossi il destinatario della chiamata. La solfa durò un paio di minuti, poi lei attaccò, senza un saluto.
“Era Jessica, un’amica.” disse, col tono grave di una sentenza.
“Ci doveva essere per forza una Jessica, in questa storia.” osservai.
“Guarda che è una cosa seria. Lei è qui sotto, insieme al mio ex ragazzo. Lui dice che vuole chiarire con me.”
“Non metterci molto.” io dissi.
“Tu scendi con me.”
“Che avrei da spartire con Fabio, il tuo ex?”
“Guarda che si chiama Mirko.”
“Già, Mirko rende meglio l’idea. Fa il carrozziere?” chiesi.
“Tu come lo sai?”
“Lasciamene indovinare una. In fondo è la prima, da stamattina.”
“Tu mi devi aiutare, Lamberto. Io l’ho lasciato ieri, mettendogli la scusa che mi sono presa per un altro. Se ti vede pensa che sia tu e si mette il cuore in pace.”
“Ti va di scherzare, Monica?”
“Guarda che Mirko è un tipo tranquillo.”
In quell’istante suonò il citofono e la voce di Jessica gracchiò dall’auricolare sfasato una sequela di parole cantilenanti e indecifrabili.
“Dice Jessica che Mirko se ne è andato. Lei gli ha spiegato la situazione e lui le ha detto di riferirci che ci aspetta tutti e due, fra una mezzora, al Cristal bar, giù all’angolo dello stradone.” lei disse.
Prima che io replicassi mi venne vicino, infilandomi una mano sotto la cinta dei pantaloni, per muovere la mia carne mentre mi baciava. Il piacere fu estremo e insolito, come un’arroganza aggressiva che mi calasse nel corpo e negli intenti, caricandomi di una sorta di onnipotenza astratta, la consapevolezza di riuscire invitto dovunque, anche da quel Cristal bar che non prometteva niente di decoroso. Facemmo l’amore in fretta, come due disperati, ma nemmeno alla fine la mia eccitazione aggressiva si placò e quando scendemmo in strada, abbracciati, mi guardai intorno cercando un pretesto, un lampo che mi accendesse di luce malfamata e di tracotanza. Alzai gli occhi al cielo di cemento, come a cercare la luce introvabile dell’innesco di quella storia che ora si stava scrivendo per suo conto, rendendomi personaggio, forse nemmeno principale, un comprimario destinato ad uscire di scena sulla porta del Cristal bar. Entrammo in macchina e partii sgassando, come l’ultimo dei coatti, mentre lei mi teneva una mano sul petto, scostando i lembi della camicia aperta. Fosse restata in silenzio per tutto il viale non avrei capito che era lei, ora, che stava creando senza nemmeno scriverlo il finale degli eventi. Invece volle strafare, strafatta di soap operas e di romanzi Harmony.
“Sei il mio eroe.” disse, e l’impatto della frase mi svegliò come uno schiaffo da un’anestesia totale.
“Allora voglio battermi con le tue insegne.” risposi, rallentando di colpo l’andatura dell’auto.
“In che senso, amore?”
“Legami attorno al braccio la tua sciarpa di seta, come facevano le dame coi loro cavalieri, nel medioevo.” dissi.
Lei non se lo fece ripetere e io le detti altri cento metri di illusione, prima di accostare la macchina, facendo la faccia basita dell’automobilista in panne.
“Che succede?” lei disse.
“Mi sa che ho forato, Fa il piacere, scendi un attimo a controllare le gomme posteriori.”
Lasciai che arrivasse dietro la macchina, picchiettando l’asfalto coi suoi trampoli, poi ripartii di scatto, guardando nello specchietto il suo stupore folgorato.
Prima di sparire dalla sua vista mi slacciai dal braccio la sciarpa, lasciandola andare nel breve volo di un turbine d’aria, che la distese sul cofano di un cassonetto, come una storia scritta male ma vissuta tutta d’un fiato.